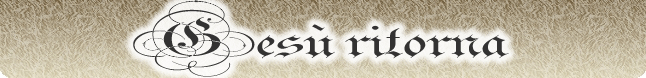C’è stato un tempo in cui la chiesa era molto potente: il tempo in
cui i primi cristiani si rallegravano di essere considerati degni di soffrire
per quello in cui credevano. Allora la chiesa non era un semplice termometro che
misurava le idee e i principi dell’opinione pubblica: era un termostato,
che trasformava il costume della società. Quando i primi cristiani entravano
in una città, le autorità si allarmavano e subito cercavano di imprigionare
i cristiani perché "disturbavano l’ordine pubblico" ed
erano "agitatori venuti da fuori". Ma i cristiani non cedettero, convinti
di essere "una colonia del cielo", chiamati ad obbedire a Dio e non
agli uomini. Erano un piccolo numero, ma la loro dedizione era grande. Erano troppo
inebriati di Dio per cedere a "intimidazioni spaventose". Con il loro
impegno e il loro esempio misero fine a mali antichi, come l’infanticidio
e lotte tra gladiatori.
Oggi la situazione è diversa. Troppo spesso la chiesa di oggi è
una voce inefficace, debole, dal suono incerto. Per lo più, la struttura
di potere di una comunità non è affatto allarmata dalla presenza
della chiesa, anzi è confortata dalla silenziosa - e spesso perfino
stentorea - approvazione dello status quo da parte della chiesa stessa.
Ma sulla chiesa incombe il giudizio di Dio, come non era mai accaduto prima. Se
la chiesa di oggi non recupera lo spirito di sacrificio della comunità
ecclesiale dei primi tempi, perderà la sua autenticità, renderà
vana la fedeltà di milioni di aderenti, e sarà messa da parte come
una associazione qualunque, priva di qualsiasi senso per il ventesimo secolo.
Tutti i giorni incontro dei giovani in cui la delusione nei confronti della chiesa
si è trasformata in vera e propria avversione.
Forse sono ancora una volta troppo ottimista. Forse la religione organizzata è
legata allo status quo da nodi talmente inestricabili da non essere in grado di
salvare la nazione e il mondo intero? Forse devo rivolgere la mia fede alla chiesa
interiore e spirituale, la chiesa all’interno della chiesa, come vera ecclesia
e speranza del mondo. Ma anche qui, sono grato a Dio che nelle file della religione
organizzata alcune anime nobili si siano liberate dalle catene paralizzanti del
conformismo e si sono unite a noi per prendere parte attiva alla lotta per la
libertà. Hanno lasciato la sicurezza delle loro congregazioni e insieme
a noi hanno percorso le strade di Albany in Georgia. Hanno viaggiato per le autostrade
del Sud nei tortuosi percorsi dei "viaggi della libertà". Si,
sono andati in prigione con noi. Alcuni sono stati espulsi dalle loro chiese,
hanno perduto il sostegno dei loro vescovi e confratelli ecclesiastici. Ma hanno
agito e sostenuti da una fede assoluta: che la giusta ragione, anche quando viene
sconfitta, è più forte del male trionfante. La loro testimonianza
è stata il sale dello spirito che in questi tempi tumultuosi ha preservato
intatto il significato autentico del vangelo. Sono riusciti a scavare una galleria
di speranza nella montagna tenebrosa della delusione.
Sentivo che qualcosa mi diceva: "Martin, devi prendere una posizione
su questo. Poco importa cosa costerà". Non ho fatto una scelta
precipitosa, non è che mi sono deciso a farlo così, da un momento
all’altro; ho avuto le mie oscillazioni, mi sono chiesto se avrei dovuto
farlo oppure no.
Mentre attraversavo questa fase, una sera mi capitò di leggere un articolo
dal titolo i bambini del Vietnam. Dopo averlo letto, dissi a me stesso: "Non
starò mai più zitto su un problema che distrugge l’anima
del nostro paese mentre distrugge migliaia e migliaia di bambini in Vietnam".
Ero arrivato alla conclusione che nella vita c’è un momento esistenziale
in cui si deve decidere di parlare per se stessi; nessun altro può parlare
al tuo posto.
Nel febbraio 1967, il filo sottile che ancora mi tratteneva minacciò
di spezzarsi quando il nostro governo respinse con sprezzo la semplice offerta
di pace – avanzata nientemeno che dal capo autorizzato dell’Unione
Sovietica – di cessare i bombardamenti sul Vietnam del Nord, non su tutto
il territorio del Vietnam, in cambio di una maggiore disponibilità al
tavolo della pace. Noi la respingemmo perché chiedevamo uno scambio di
vantaggi militari.
Rivolgendo lo sguardo indietro, riconosco che la mia perdita di fiducia non
fu improvvisa: si produsse con lo slancio di una marea montante. Passando in
rassegna gli eventi, vedevo un accumulo ordinato di male, un sommarsi di atti
disumani, uno solo dei quali sarebbe bastato a indurre un uomo a nascondersi
per la vergogna. Il fatto doloroso, ma vero, era che il mio paese si limitava
a parlare di guerra, ma in realtà tendeva con ogni mezzo alla vittoria
militare. Il guanto della pace racchiudeva il pugno serrato della guerra. Il
senso di colpa e di vergogna mi lasciavano nudo ed esposto, come avrebbe dovuto
sentirsi ogni tedesco quando il suo governo usava la potenza militare per sopraffare
altre nazioni. Quali fossero i torti e le ragioni, troppo a lungo mi ero concesso
di rimanere uno spettatore silenzioso. Nel migliore dei casi, mi ero espresso
con parole fragorose, ma con atti sommessi, mentre sotto i miei occhi si svolgeva
una messinscena, una finzione.
Tante volte avevo rimproverato con disprezzo coloro che con il silenzio e l’inattività
lasciavano che si perpetuassero i mali dell’ingiustizia razziale, e quindi
contribuivano a provocarli. Non avevo forse più e più volte che
lo spettatore silenzioso deve assumersi la responsabilità delle azioni
brutali commesse da chi aveva assassinato dei bambini innocenti in una chiesa
di Birmingham? Non avevo forse propugnato il principio che distogliere lo sguardo
dal male equivale di fatto ad autorizzarlo? Quelli che commettono linciaggi,
premono il grilletto, usano il pungolo da bestiame, agiscono in nome di chi
rimane in silenzio. Perciò dovevo parlare, si volevo cancellare il mio
nome dalle bombe che cadono sul Vietnam del Nord o del Sud, dai fusti di napalm.
Era arrivato il momento in cui dovevo sconfessare coloro che in nome della pace
incendiano, mutilano,uccidono, e dovevo dissociarmi dai loro atti.
Nel 1957, un funzionario Americano dotato di sensibilità disse che
secondo lui il nostro paese sembrava situato nel versante meno vantaggioso di
una rivoluzione mondiale. Negli ultimi dieci anni abbiamo visto affiorare uno
schema di repressione che oggi giustifica la presenza di consulenti militari
statunitensi in Venezuela: La necessità di mantenere la stabilità
sociale per favorire i nostri investimenti spiega l’opera controrivoluzionaria
compiuta dalle forze americane in Guatemala; spiega come mai contro i guerriglieri
cambogiani si usino elicotteri americani, come mai contro i ribelli in Perù
siano già stati usati napalm americano e le truppe dei berretti verdi.
Riflettendo su queste attività, le parole del compianto John F. Kennedy
tornano ad ossessionarci; cinque anni fa Kennedy disse: "Coloro che rendono
impossibile la rivoluzione pacifica renderanno inevitabile la rivoluzione violenta".
Per scelta o per caso, la nostra nazione si è investita sempre più
spesso di questo ruolo: il ruolo di coloro che rendono impossibile una rivoluzione
pacifica, rifiutandosi di rinunciare ai privilegi e ai piaceri derivanti dagli
immensi profitti degli investimenti in tutto il mondo. Io sono persuaso che
se vogliamo passare al versante positivo della rivoluzione mondiale, come nazione
dobbiamo compiere una radicale rivoluzione dei valori. Dobbiamo al più
presto cominciare a passare da una società orientata alle cose a una
società orientata alle persone. Finché considereremo le macchine
e i computer, le motivazioni del profitto e i diritti di proprietà più
importanti delle persone, i tre giganti del razzismo, del materialismo estremo
e del militarismo non potranno mai essere sconfitti.
Una vera rivoluzione dei valori ci indurrebbe ben presto a mettere in discussione
l’equità e la giustizia di molte nostre scelte politiche del presente
e del passato. Da un lato siamo chiamati a operare come il buon samaritano sul
ciglio della strada della vita, ma questo è soltanto il principio: un
giorno dovremo arrivare a capire che bisogna arrivare a trasformare l’intera
strada per Gerico, in modo che gli uomini e le donne non continuino a essere
pestati e rapinati mentre sono in viaggio sull’autostrada della vita.
La vera compassione non si limita a gettare una moneta al mendicante, ma arriva
a capire che, se produce mendicanti, un edificio ha bisogno di una ristrutturazione.
Una vera rivoluzione dei valori metterà mano all’ordinamento mondiale,
e della guerra dirà:"Questo modo di comporre i dissidi non è
giusto". Bruciare gli esseri umani con il napalm, riempire le nostre case
di orfani e di vedove, iniettare germi velenosi di odio nelle vene dei popoli
che di norma sarebbero pieni di umanità, rimandare a casa gli uomini
che hanno combattuto in campi di battaglia tenebrosi e sanguinosi e tornano
menomati nel fisico e turbati nella psiche: tutti questi atti non possono conciliarsi
con la saggezza, la giustizia, l’amore. Una nazione che continua, un anno
dopo l’altro, a spendere più denaro per la difesa militare che
per i programmi di elevazione sociale, si avvicina alla morte dello spirito.
Appena mi dichiarai contrario alla guerra in Vietnam, quasi tutti i giornali
del paese mi criticarono. Fu un periodo nero. Non potevo quasi aprire un giornale,
e non erano soltanto i bianchi, erano i negri. Poi, però ricordo un giornalista
che un giorno venne a dirmi:"Professor King, non crede di dover modificare
la sua posizione, visto che sono così tanti a criticarla? Sta perdendo
il rispetto che una volta le persone avevano nei suoi confronti. E immagino
che la sua posizione provocherà danni anche all’associazione: sono
stati annunciati tagli ai finanziamenti. Era una buona domanda: il giornalista
mi chiedeva se in questa situazione intendevo pensare a quel che sarebbe accaduto
a ma, oppure a quel che sarebbe accaduto alla verità e alla giustizia.
In certe situazioni, la vigliaccheria domanda: "E’ una cosa sicura?".
E l’utilitarismo domanda:" E’ politicamente opportuno?".
Poi arriva la vanità a domandare: "E’ una cosa che ha il
favore del pubblico?". Ma la coscienza domanda: "E’ Giusto?".
E arriva il momento in cui si deve prendere una posizione che non è sicura,
non è opportuna politicamente, non riscuote il favore del pubblico: però
si deve fare così, perché la coscienza dice che è giusto.
In ultima analisi, un uomo non si misura dalla posizione che assume nei momenti
di convenienza, ma da quella che assume nel cimento, nelle grandi crisi e controversie.
Ed è qui che oggi scelgo di tentare la mia sorte. Ed è per questo
che voglio andare fino in fondo così. Altri forse vorranno prendere altre
direzioni, ma quando ho preso la croce ne ho riconosciuto il senso: non è
una cosa su cui ci si limita a posare le mani; non è una cosa che si
porta addosso. La croce è una cosa che si porta e, in ultima analisi,
su cui si muore. La croce può voler dire la morte della tua popolarità;
può voler dire la fine del tuo ponte diretto con la Casa Bianca; può
voler dire la fine di una donazione, ma voi raccogliete la vostra croce e portatela
lo stesso. Ed è così che io ho deciso di fare. Avvenga quel che
può, ormai non ha più importanza.